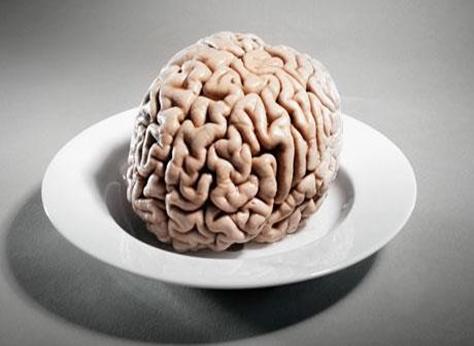Introduzione
Lo so, sto un po’ in fissa con questa cosa, ma
continuo a trovare documentazione aggiornata che insiste nel riportare
quest’immagine, persino in un libro di testo per la scuola media edito soltanto
un paio d’anni fa! Insomma, va bene che si fa fatica ad accettare quanto la
moderna paleoantropologia, la genetica molecolare e/o l’archeologia ci
raccontano da meno di dieci anni, va bene capire la fatica di riscrivere quanto
fino a poco fa si considerava accettabile, ma è proprio questo uno dei ruoli
della scienza: rivedersi.
Per quanto riguarda la fissa suddetta qui,
ma soprattutto qui,
potrete trovare altri post sull’argomento.
Schema di
classificazione delle catarrine esistenti (in inglese ape e monkey indicano
rispettivamente primati di grandi dimensioni, come i gorilla o gli scimpanzè, e
le piccole scimmie) - Science, 2010
L'immagine
dell'evoluzione umana rappresentata in quel modo lineare, progressivo, in cui
c'è un nostro presunto antenato molto simile a una scimmia che si trasforma
gradualmente e lentamente in un essere umano, è solo una ricostruzione semplicistica
che vede sempre come culmine all'estrema destra di questa carrellata di nostri
parenti un Homo sapiens, tra l’altro sempre un maschio bianco; un’icona considerata
all'apice della storia umana. Si fa fatica ad accettare che sia sbagliata
perché quella sbagliata è un'immagine che ci gratifica, affascina, colpisce e consola.
La grande iconografia della speranza umana che quella
è la storia, la giusta conclusione del percorso che,
necessariamente, doveva
condurre fino a noi. E soprattutto è un modello semplicissimo, persino i
bambini lo capiscono: poche idee chiare e dirette…ma sbagliate!
Rappresentazione
alternativa alla precedente
Più tentativi, più successo
Sbagliate perché quello che
sappiamo oggi dell'evoluzione è quanto rappresentato nell’immagine seguente,
parte di un articolo
di Terry Harrison pubblicato sul numero 327 di “Science” nel febbraio del 2010.
L’immagine rappresenta schematicamente le relazioni tra ominoidi (ominidi o scimmie) in
prospettiva temporale, a partire dalle primissime scimmie primitive, agli inizi
del Miocene, passando dalla biforcazione avvenuta circa 6 milioni di anni fa,
data della comparsa dell’antenato comune tra i
generi che hanno portato fino ad Homo sapiens e gli altri rappresentanti
degli ominidi, ovvero scimpanzè, oranghi, bonobi e forse anche i gibboni.
Le barre grigie continue rappresentano l'intervallo di tempo noto di ciascun genere,
sottili linee scure sono relazioni dedotte tra i generi e sottili linee
tratteggiate con un punto interrogativo denotano relazioni incerte.

Dentro
quella fascetta degli ominini
comparsa meno di due milioni di anni fa c’è tutta la storia evolutiva che ha
portato fino ad Homo sapiens, ma ci sono anche gli altri Homo, e poco prima, in
termini geologici, c’erano ad esempio gli australopitechi come la famosissima Lucy,
nella ricostruzione qui a fianco.
Schema relazionale
tra Hominoidea in prospettiva temporale - Science, 2010
Schema evolutivo e
relazioni delle forme preumane (arancione) ed umane (azzurro) - Pievani, 2019
Un cespuglio intricato
Si osservi invece il cespuglio di forme dell’immagine precedente: un modello che ne evidenzia la loro ramificazione e che rappresenta le relazioni, le parentele tra queste. In basso a destra gli appunti in proposito presenti su uno dei quaderni di Charles Darwin: la straordinaria intuizione!
Una storia lunga e complessa e
andando dentro quelle fascette colorate, che rappresentano generi, ci sono
quindi complessi di specie diverse, potete apprezzarne la quantità. Moltissime
sono dei vicoli ciechi che ci hanno preceduto. Ominini: già, siamo diventati
una sottofamiglia di questo cespuglio di forme che si sono diversificate molto
recentemente, sempre in termini geologici. E quanti punti interrogativi, perché
non abbiamo informazioni sufficienti, perché non riusciamo a ricostruire molti
rapporti di parentela in ciò che viene prima di Homo sapiens. Ma è certo che
siamo parte di un cespuglio ramificato con oltre venti specie diverse: non siamo mai stati soli, la nostra è una storia plurale.
Adesso consideriamo quest’altra
rappresentazione, col tempo che passa in verticale e qualche dettaglio in più.
La linea ondulata nera rappresenta un limite evolutivo tra primati preumani ed
umani: da quel momento in poi si assiste ad una continua e progressiva crescita
delle dimensioni del cervello man mano che procede l’evoluzione delle varie
specie.
Pievani, 2019
In base alle ultime ricerche siamo
comparsi in Africa 200.000 anni fa, forse 300.000, una specie giovane
che ha appena iniziato la propria storia evolutiva. Ma ecco la scoperta più
sconvolgente di questi ultimi anni, talmente sorprendente che molti scienziati
faticano ancora a interiorizzarla, inaspettata com’è.
Se avessimo potuto viaggiare
sulla Terra, tra Africa e Asia, 50.000 anni fa, un battito di ciglia rispetto
al tempo geologico profondo, il tempo necessario a formare uno strato sottile
di roccia sedimentaria, avremmo incontrato non una ma ben cinque specie umane.
Se la storia dell’evoluzione umana degli ultimi due milioni di anni fosse rapportata
a 24 ore noi saremmo apparsi da un paio d’ore! Ma non da soli. La Terra era già abitata da più forme umane, diverse
tra loro, specie cugine, ma con storie ambientali molto diverse a creare una
sorta di biodiversità umana.
Nel cespuglio lussureggiante
degli ominini si scopre inoltre che specie ritenute sequenziali hanno in realtà
avuto lunghissimi periodi di evoluzione parallela, in altre parole di
convivenza sullo stesso pianeta e magari negli stessi territori, per centinaia
di migliaia di anni.
Le nozioni monolitiche di “uomo
primitivo” e di “ambiente ancestrale” perdono di significato: non vi è traccia
né di una specie unica né di un ambiente ancestrale omogeneo.
Inconcepibile? Diamo per scontato
di essere gli unici umani del pianeta, ci sentiamo molto orgogliosi guardando
un gorilla allo zoo negli occhi, accettiamo il fatto che possa essere un nostro
cugino stretto ma un retropensiero ci ricorda immediatamente che no! siamo
diversi, noi umani, loro un’altra cosa. La solitudine della nostra
storia è un’illusione da un punto di vista evoluzionistico, e nell’ultimo
tratto del nostro percorso ne siamo stati la causa, perché il primo evento di
estinzione della biodiversità umana, e non solo, è stato provocato da Homo
sapiens che, in qualche modo, non necessariamente violento, ma soprattutto per
lenta sostituzione come avvenuto con i Neandertal, si è liberato dei parenti,
estinguendoli, in un arco di tempo che probabilmente va dai 30.000 ai 12.000
anni fa: vicinissimi dunque alla soglia della storia che si studia a scuola,
vicinissimi alla comparsa delle prime civiltà, ancora più vicine alla
cosiddetta rivoluzione neolitica, con la comparsa dell’agricoltura e della
domesticazione di specie animali. Gli ultimi Neandertal si estinguevano poche migliaia di anni
fa.

Direttrici della
prima ondata migratoria delle specie umane fuori dall’Africa
(Istituto Geografico De Agostini)
Out of Africa!
Ma facciamo un passo indietro e passiamo
dal tempo allo spazio.
A partire da circa 2 milioni di
anni fa le specie preumane africane iniziano a produrre un comportamento
anomalo mai visto prima e che probabilmente è proprio ciò che ci ha reso umani:
migrare, spostare il nostro areale di distribuzione, a differenza dalle scimmie
antropomorfe abituate a nascere in un posto ed a restarci. La mobilità è una
caratteristica fondamentale delle specie umane, quale miglior prova l’attuale
mondo iperglobalizzato? La mappa precedente, realizzata con la collaborazione
del prestigioso Istituto Geografico De Agostini di Novara, illustra la prima
grande diaspora dell’umanità, la cosiddetta Out of Africa 1, iniziata
circa due milioni di anni fa.
Nella mappa è possibile osservare
come siano stati ricostruiti anche i profili delle linee di costa nei periodi
glaciali, coincidenti con abbassamenti anche notevoli del livello medio dei
mari protrattisi per lunghi periodi: Africa ed Asia erano agganciate in un
unico grande continente, e quest’ultima, laddove ora c’è il mare dello stretto
di Bering, era collegata alle Americhe attraverso la Beringia, da cui prende il
nome, un istmo di terra emersa. Era quindi possibile muoversi senza incontrare
ostacoli dal sud Africa al sud America.
L’instabilità ecologica e i
cambiamenti climatici sono stati le cause principali che hanno spinto i nostri
antenati a spostarsi, unitamente alle enormi capacità di adattamento ad
ambienti diversi con grandissima flessibilità, una plasticità adattativa che,
se da una parte ha fatto la nostra fortuna, dall’altra potrebbe ribaltarsi a
nostro sfavore visto che, come ha detto qualcuno, siamo diventati una specie
cosmopolita invasiva: abbiamo occupato
tutti gli ecosistemi possibili, persino quelli più estremi e meno ospitali.
Impossibile? Ipotizziamo un
avanzamento di appena 10 chilometri ogni secolo: in 10.000 anni, anche se la densità
demografica di stimata era di un individuo ogni 10 chilometri quadrati, gli
appartenenti ad una determinata specie avrebbero potuto coprire una distanza di
1.000 chilometri. Con questi valori è semplice constatare che, nei 200.000
trascorsi dalla comparsa delle prime forme di Homo sapiens in Africa centrale,
ai primi ritrovamenti di ominini in Asia orientale si può ipotizzare uno
spostamento potenziale di 20.000 chilometri. Senza considerare che erano
presenti altre forme umane migrate in precedenza.
La prima grande migrazione
iniziava due milioni di anni fa e si è ripetuta almeno altre due volte.
Direttrici della
seconda ondata migratoria delle specie umane fuori dall’Africa
(Istituto Geografico De Agostini)
La cosiddetta Out of Africa 2 è
iniziata circa 800.000 anni fa: di nuovo altre forme umane lasciano l’Africa,
tra l’altro sempre dalla stessa zona, e questo dato è affascinante: tutte le
grandi migrazioni umane che hanno prodotto anche la diversità attuale umana
partono tutte dal Corno d’Africa. Come lo sappiamo? Ce lo dicono in modo
estremamente preciso le molecole del DNA mettendoci in grado di collocare il
punto e la data precise di inizio di queste migrazioni.
Ogni volta rappresentanti di
specie Homo diverse, anche in piccolissimi gruppi di qualche decina di
individui, sono partiti dalle vallate tra Eritrea, Etiopia, Kenya e Tanzania e
da lì, seguendo corridoi naturali, ad esempio quello del Nilo od altri, sono
arrivati in Medio Oriente, punto di smistamento fondamentale verso rotte
dirette al nord, verso l’Europa, o verso est. Oppure con percorsi di migrazione
che, seguendo la costa meridionale della penisola araba, doppiando il
continente indiano a sud, hanno raggiunto quello che allora era un unico
lunghissimo territorio che dalla Malesia, passando per l’Indonesia arriva a
quello che oggi è Papua-Nuova Guinea, e isola dopo isola, o su strisce di
territorio emerso, hanno raggiunto l’Australia forse già 80.000 anni fa.
Questa è l’ondata migratoria che
ha visto uscire dall’Africa forme umane antecedenti a quanto in seguito,
esclusivamente sul continente europeo, sarebbe stato indicato come Homo neandertalensis,
un’esclusiva del vecchio continente, qui presenti fin da 300.000 anni fa.
Il percorso geografico e quello
evolutivo che ha portato gli esseri umani dal Corno d’Africa al Mediterraneo, e
quindi all’Europa e al Medio Oriente, è ciò che ci ha reso umani. Spostarsi da
ambienti inospitali, muoversi attraverso tracciati diversi causati dalle
diverse condizioni climatiche della zona del Sahara, che ha avuto diversi
cicli, con lunghi periodi di fertilità seguiti a periodi altrettanto lunghi di
aridità, attirando o respingendo le popolazioni umane: tutto ciò che ha
provocato ondate migratorie ci ha reso umani. Fino alla cosiddetta Out of
Africa 3, che sembra aver interessato soltanto Homo sapiens.
E tutto
questo mi rende impossibile non pensare alle famiglie che oggi lasciano i
propri paesi di origine, mettono a rischio la vita dei loro stessi figli, per
imbarcarsi in un viaggio della speranza in cerca di migliori condizioni di vita.
Direttrici della
terza ondata migratoria delle specie umane fuori dall’Africa
(Istituto Geografico De Agostini)
Dappertutto
E questa terza grande ondata fuori dall’Africa riguarda proprio noi, Homo
sapiens, a differenza delle precedenti che riguardarono specie diverse. Anche
Homo sapiens arriva dapprima in Medio Oriente e poi lungo la costa meridionale
del Mediterraneo, affiancato da un’irruzione in Europa oltre che da percorsi
migratori verso nordest e sudest.
Anche Homo sapiens è una specie immigrata. La specie
autoctona europea erano i Neandertal, già presenti e comparsi proprio in questo
continente oltre 300.000 anni fa.
Una scoperta recente, sempre
grazie alla genetica molecolare, ha evidenziato che i geni connessi allo
schiarimento della pelle in Homo sapiens hanno circa 16-18.000 anni.
Considerando che l’arrivo di Homo sapiens in Europa è iniziato circa 40.000
anni fa, è evidente che i primi immigrati di colore in Europa siamo proprio noi,
magari con gli occhi azzurri, predecessore dell’Uomo di Cheddar, come
nella ricostruzione qui a fianco di un Sapiens, ma con la pelle scura. Successivamente ci sono state
diverse altre ondate migratorie, alcune che sembrano esser fallite a causa di
stravolgimenti climatici che, in qualche modo, hanno come sbarrato la strada ai
gruppi che migravano, altre spintesi in avanti anche per decine di migliaia di
chilometri dal luogo di origine.
Tra queste forse la più
importante è quella di circa 75.000 anni fa, più invasiva delle
precedenti.
La migrazione
finale? - Pievani, 2019
Ricostruzione
morfometrica esatta delle sembianze di un Neandertal
a confronto con una bambina Sapiens
Incontri ravvicinati di tipo
primitivo
E non è tutto. L’immagine
precedente, un Neandertal e una bambina Sapiens, ci racconta qualcosa che è
accaduto veramente. Le due specie, strettamente imparentate l'una con l'altra,
sono vissute negli stessi territori a lungo, e quindi davvero non siamo stati
soli in Medio Oriente, in Europa, e principalmente in Italia, in Francia e in
Spagna, così come nelle vallate prealpine abbiamo zone di sovrapposizione di popolamento
nello stesso periodo di più specie umane, e in particolare di queste due specie
umane. Ci distingueva soltanto lo 0,1% del DNA. Ed eravamo talmente vicini dal
punto di vista biologico da essere interfecondi, potendo generare individui a
loro volta fecondi, e i risultati delle ibridazioni tra Sapiens e Neandertal
sono evidenziati dalla presenza nel nostro di DNA di materiale genetico dei
nostri cugini. I dettagli genetici di questi scambi sono ancora oggetto di
studio e ci sono molti dubbi sui meccanismi di trasmissione e di diluizione
delle componenti delle due specie, ma è certo che i due gruppi possano aver
avuto rapporti più che amichevoli. Per chi volesse approfondire qui
potete trovare il materiale adatto.
In
quel periodo i Neandertal avevano già iniziato quanto è noto come sviluppo
dell’intelligenza simbolica, processo interrotto dalla loro estinzione avvenuta
circa 28-29.000 anni fa. L’ultima comunità Neandertal sopravvisse
attorno alla Rocca di Gibilterra con una dozzina di famiglie che, in maniera
progressiva e non drammatica furono lentamente sostituiti dai Sapiens che hanno
portato ad una marginalizzazione di quest’altra forma umana, che infatti scompare
progressivamente dal Medio Oriente all’inizio, poi dall’Anatolia verso i
Balcani, Italia, Francia e infine Spagna, come se fosse schiacciata verso
occidente dalle continue ondate di ingresso di Homo sapiens in Europa.

Dall’altra
parte del mondo, sull’isola di Flores in Indonesia, fino a soltanto 12.000 anni
fa, ha vissuto un’altra spece umana, Homo floresiensis (nell’immagine a
sinistra una femmina a confronto con una Sapiens), una specie pigmea a causa
del cosiddetto nanismo insulare: erano infatti alti circa un metro ma con un cervello ben
sviluppato. Un’altra forma umana arrivata fino alle soglie della storia; se
questa specie avesse resistito qualche altro millennio avrebbe visto i primi
campi coltivati, le prime città. Siamo
soli da pochissimo tempo. E a questo proposito c’è una domanda che non
avrebbe avuto senso porre anche solo un paio di decenni fa, quando si dava per
scontato che dopo l’estinzione delle altre forme umane, i Sapiens fossero gli
unici rimasti grazie ai migliori adattamenti espressi.
Perché invece siamo soli se fino
alle soglie della storia c’erano almeno quattro, se non cinque, forme umane
diverse?
E’ una domanda a cui è tuttora
difficile rispondere ma è ovvio che noi siamo soltanto
uno dei modi di essere umani, un’altra prova dei meccanismi
dell’evoluzione per selezione naturale che ci dice che, se potessimo
riavvolgere il nastro all’indietro e ripartire da capo, per ogni linea
evolutiva di qualsiasi organismo vivente, potremmo avere infinite possibilità
di futuri diversi.
L’origine
delle attuali popolazioni
Cervelloni
Avere un grande cervello, con la
parte dedicata ai lobi frontali ben sviluppata, sicuramente ha aiutato. Ma
anche questo è un effetto collaterale dell’evoluzione, non è il prodotto delle
pressioni selettive.
Un’eccezionalità genetica,
assente in tutte le altre forme imparentate, provoca un rallentamento mai visto
prima del periodo di crescita e in particolare del periodo infantile e
adolescenziale (neotenia); in pratica,
restiamo bambini molto più a lungo di qualsiasi altra specie a noi
prossima. Persino nei confronti dei Neandertal: è stato dimostrato che un
appartenente a questa specie diventava adulto due anni e mezzo prima dei
Sapiens. Nella nostra specie il mantenimento dei tratti infantili permane molto
più a lungo e la nostra è l’unica specie in cui il cervello continua a crescere
anche dopo il parto per almeno altri due anni.
Dal punto di vista
evoluzionistico queste caratteristiche rappresentano costi di adattamento molto
elevati: un grande cervello che da solo consuma oltre il 20% dell’energia
dell’organismo, molto esigente dal punto di vista metabolico, ma soprattutto
cuccioli fragili per più anni rappresentano un investimento parentale consistente,
e quindi questa innovazione ha avuto come necessità di altri bilanciamenti nell'organizzazione
sociale. La necessità di tenersi nel gruppo cuccioli fragilissimi per molti più
anni ci ha evidentemente regalato qualcos’altro: l’espansione del periodo di apprendimento, di gioco, di imitazione,
alimentando la plasticità umana, con un cervello letteralmente plasmato biologicamente
dalle esperienze successive alla nascita, grazie anche allo sviluppo del
cervello successivamente al parto che, fra i suoi effetti collaterali ha
prodotto un aumento delle capacità craniche. Per motivi meccanici, legati alle
dimensioni del canale del parto delle donne Sapiens, nasciamo con un cervello che
continua ad espandersi successivamente, soprattutto nell’area della corteccia
prefrontale: un effetto collaterale di un processo di sviluppo. Quindi questa
specie che rimane bambina così a lungo diventa una specie capace di
avere una vita sociale molto elaborata e in piccoli gruppi.
Tutto ciò ad ulteriore
testimonianza che la teoria dell’evoluzione, mantenendo ben saldi i principi
darwiniani, è molto più pluralista e flessibile, con la selezione naturale che interagisce
con molti altri fattori tra i quali quelli dello sviluppo che sono essenziali.
Oggi la teoria dell'evoluzione è qualcosa di molto complesso ed altrettanto
interessante che non l’idea, ormai semplicistica, che le pressioni selettive
siano soltanto una sorta di problem solving atto al mutare delle
condizioni ambientali.
La sintesi neodarwinista estesa - Pievani, 2019
Prede
Phillip Tobias (nella foto a fianco), un eminente antropologo, dimostrò che i segni di trauma riscontrati sul
cranio di un fossile di cucciolo di australopiteco vissuto circa 2,8 milioni di
anni fa (il Bambino
di Taung) non erano, come si diceva fino a pochi anni fa, segni di riti di cannibalismo, attribuendo
chissà quale valore mistico ed esoterico al ritrovamento, ma i traumi riportati
a seguito dell’esser stato cacciato da un’aquila. Segni conformi a quanto si
può ritrovare ancora oggi in cuccioli di scimpanzè predati da rapaci. Sappiamo quindi oggi, con ragionevole
certezza, che per gran parte della nostra storia non siamo
stati predatori ma prede; molti degli adattamenti sociali che abbiamo
sono adattamenti da prede e non da predatori, adattamenti difensivi, cambiando
quindi la prospettiva sull’evoluzione.

E con
ciò si smontano anche alcuni dogmi, dovuti a narcisismo e pregiudizi,
presenti sui testi fino a non molto tempo fa (direi ancora oggi). Tra i tanti “il
nostro cervello è diventato grande perché eravamo grandi cacciatori e ci
nutrivamo di carne fresca in abbondanza”. Ma la realtà era ben diversa.
Siamo diventati grandi cacciatori in tempi molto recenti, lunghi abbastanza
comunque da consentirci di sterminare
tutte le macrofaune esistenti man mano che la migrazione ci portava a
colonizzare la quasi totalità degli ambienti. Abbiamo infatti passato più del
90 percento della nostra storia di specie come necrofagi e saprofagi, come spazzini
della savana, contendendoci le prede con avvoltoi e iene; dopo tutto è un
comportamento molto adattativo perché la grande fatica della cattura la si
lascia ai predatori professionisti, cioè i grandi felini, andando poi a
sottrarre quel che resta, pezzetti di carne già ben frollata, essenziale per
nutrire il cervello che, come predetto, assorbe da solo il 22 percento
dell’energia del metabolismo umano, e da associare a quanto di vegetale fosse
disponibile direttamente con la raccolta. Quindi niente lancia in resta
e caccia al mammut se non in tempi più recenti ma una dieta onnivora con cui
Homo sapiens se l’è cavata egregiamente. Per tornare al narcisismo che ci
ha visto e ci vorrebbe ancora come i dominatori del mondo da sempre voglio
ricordare le parole di una grande biologo, Stephen Jay Gould: «Pensiamo che il problema fosse alzarsi la mattina e chiedersi
cosa mangiare; in realtà il problema essenziale era arrivare a fine giornata
senza esser stati mangiati».
Conclusione
Homo sapiens, dunque, è uscito
dall’Africa a più riprese, siamo una specie molto giovane, nata in Africa
300.000 anni fa, più o meno 10.000 generazioni umane, e prima oltre che contemporaneamente
alla nostra, altre specie hanno affrontato grandi migrazioni più volte nel
corso della loro storia evolutiva. La mobilità è stata quindi la risposta
adattativa ai cambiamenti ecologici. Dall’Eurasia all’Australia e poi nelle
Americhe. Una bellissima storia ma che è tuttora in corso di svolgimento.
Anche oggi le popolazioni umane
si spostano, nonostante i confini politici che spesso rappresentano delle vere
e proprie barriere fisiche da attraversare, persino a volte con maggiori
difficoltà che guadare un fiume o valicare un passo di montagna. Le Nazioni
Unite hanno previsto spostamenti dovuti al cambiamento climatico dell’ordine
delle decine di milioni di persone, in corso: il fenomeno migratorio è
costitutivo della nostra identità di specie ma costituisce anche il nostro
presente e sarà anche il nostro futuro. Una verità un più sconcertante più
scomoda, che però va raccontata non limitandosi soltanto al passato remoto come
se quel che Homo sapiens fece allora fosse appunto relegato al passato. Per raccontare
l'evoluzione del lontano passato occorre capire il presente, avere delle chiavi
di lettura per capire cos'è una pandemia,
che cos'è la biodiversità, che cos'è il cambiamento ecologico: l'evoluzione è
una chiave di lettura per il presente e per il futuro, ecco perché fa tutto
parte del racconto.
E lo scopo principale è
contrastare aspramente le derive negazioniste, razziste, persino tentativi di
fare eugenetica, come ad
esempio fatto da parte di genetisti truffaldini con uno spin-off dell’università
di Budapest che hanno avuto la deleteria idea di usare la genetica per dimostrare
identità, tratti somatici, purezza
della razza e dell’ascendenza, a riprova che non ci siano impurità
ebraiche o di origine rom o sinti. Questo può accadere oggi perché l'idea di
identità associata all'idea di DNA porta a queste follie! Così come meno
gravemente ma non meno sottilmente chiunque studia l'evoluzione deve sobbalzare ed
opporsi con fermezza ogni volta che qualcuno dice che abbiamo la guerra
scritta nel DNA, che i maschi sono aggressivi e violenti per natura e
via discorrendo. Ogni volta occorrerebbe chiedere, a chi pronuncia oscene
fesserie del genere, cosa intenda per natura, cosa intenda con scritto nel DNA. Gridare
con forza che le razze non esistono non significa non voler essere razzisti,
questo è il minimo ed è anche ovvio, e nemmeno perché non si vuole essere politically
correct: non esistono e basta per motivi tecnici, per motivi sperimentali,
per motivi empirici, ovvero per motivi interni alla comunità scientifica e non
per motivi politici. Ed a maggior ragione per contrastare il clima crescente
che impedisce di fare affermazioni del genere senza essere tacciati d’essere
schierati politicamente, in questo caso con la sinistra. Fino ad una quindicina
d’anni fa si poteva prender parte ad una trasmissione e dichiarare, motivandolo
scientificamente, che le razze non esistono; oggi si verrebbe bersagliati da
arrabbiatissimi ascoltatori che direbbero che si sta facendo politica, che in
studio si sono invitati i soliti…comunisti o, nella migliore delle
ipotesi un perbenista politically correct! Posizione quest’ultima di cui
si può venir accusati persino parlando di riscaldamento climatico, visto che
qualcuno sta cercando di passare la lotta al cambiamento climatico come un tema
del genere!
____________________________________________________________________________
Riferimenti bibliografici
Guido Barbujani, Come eravamo.
Storie dalla grande storia dell’uomo. 2022
Guido Barbujani, Andrea
Brunelli. Il giro del mondo in sei milioni di anni. 2018
Telmo Pievani. Homo sapiens ed
altre catastrofi. 2002
Telmo Pievani. Ripensare l’evoluzione
umana. 2019
Guido Chelazzi. L’impronta
originale. Storia naturale della colpa ecologica. 2013