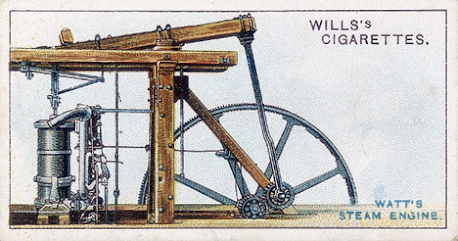Premessa
Un compito fondamentale della COP è quello di rivedere le
comunicazioni nazionali e gli inventari delle emissioni presentati dagli stati
membri. Sulla base di queste informazioni, la COP valuta gli effetti delle
misure adottate e i progressi compiuti nel raggiungimento dell’obiettivo finale
della convenzione.
La COP si riunisce ogni anno, salvo diversa decisione. La
prima riunione della COP si è tenuta a Berlino, in Germania, nel marzo 1995.
Per chi volesse approfondire qui
potrà trovare l’elenco di tutte le COP tenutesi finora ed accedere agli atti.
Mi sono già occupato di una COP, la COP26, e non credo che avrei molto da aggiungere se volessi commentare quella dell’anno scorso o, una volta terminata, quella in arrivo. Ma ciò che mi colpisce quest’anno è la sede prescelta, perché non ad Hong Kong allora? Certo, una sede vale l’altra, più o meno, visto il contributo notevole che le città apportano alle emissioni totali di gas serra, ma la scelta di Dubai rimane per me curiosa, così come, lo vedremo a breve, lo sarebbe stato o lo sarebbe un domani, Cina permettendo, scegliere Hong Kong.
E, tanto per tornare in tema di COP28 aggiungo che questa parte già
abbastanza in salita: innanzi tutto all’ombra dello sfarzo della città e dei
suoi cittadini, 43.000 €/anno di reddito pro capite, le notizie che giungono
sul trattamento
dei lavoratori immigrati, soprattutto quelli all’opera sul cantiere degli
edifici che ospiteranno la conferenza e, più in generale, i piani che i singoli
stati membri, persino i più virtuosi, hanno intenzione di attuare per contenere
le emissioni di gas serra sono decisamente insufficienti, e questo è un
argomento scottante del quale si parla da parecchio
tempo. [ironia on]Però ci sarà il Papa.[ironia
off](*)
Per il resto nulla da segnalare sul fronte delle notizie sul cambiamento climatico in atto. Persino la prestigiosa rivista inglese “The Lancet” non fa altro che confermare, sottolineare e ribadire i rischi, dell’inarrestabile processo in corso; e lo fa mettendoci, come si dice, il carico, trattandosi tutto sommato di una rivista di estrazione medica e clinica, sottolineando inoltre i rischi per la salute dell’umanità.
Dubai
Le città contribuiscono alle emissioni bruciando ad esempio combustibili fossili prodotti altrove; oppure, proprio come nel caso degli Emirati, possono anche essere un fiore profumato dal punto di vista delle emissioni ma i loro prodotti, esportati nel mondo e consumati, contribuiscono alle emissioni.
La crescente tensione che sta scuotendo il Medio Oriente a partire dallo scorso ottobre, sebbene latente da tempo, dovrebbe fungere da monito per tutti i principali consumatori, soprattutto per coloro che importano idrocarburi, affinché accelerino il passo nella transizione energetica. Questo imperativo non solo risponde alla necessità di contrastare il cambiamento climatico, ma anche di garantire la sicurezza energetica e l'autonomia strategica.
La strategia dei paesi arabi invece mira chiaramente a massimizzare lo sfruttamento delle considerevoli riserve petrolifere, rappresentanti oltre la metà delle risorse globali, finché il mercato del greggio mantiene la sua rilevanza e prima che sia gradualmente sostituito.
Analogamente, il Qatar sta perseguendo una strategia simile nel settore del gas naturale, prevedendo un aumento del 60% nella capacità di liquefazione ed esportazione entro il 2027. L'obiettivo è chiaro: capitalizzare sulle risorse di idrocarburi disponibili, finanziando allo stesso tempo il percorso verso la transizione energetica ed economica. Questo percorso li renderà progressivamente autonomi dagli introiti derivanti dai combustibili fossili. Un esempio tangibile di questa visione è rappresentato dagli ingenti investimenti in tecnologia, servizi, turismo e, più recentemente, nel settore calcistico.
Questa dipendenza persistente dal petrolio e dal gas potrebbe portare gli stati che non riescono o non intendono liberarsi da tale dipendenza a trovarsi in un mercato degli idrocarburi ancor più oligopolistico rispetto a quanto lo sia attualmente. Secondo le proiezioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), anche nello scenario più ottimistico necessario per raggiungere l’ambizioso obiettivo di net zero emissions e entro il 2050, il Medio Oriente aumenterà la sua quota di produzione globale di petrolio e gas dal 25% attuale al 40% nel 2050, sebbene su volumi inferiori. Ricordo che la terminologia zero netto si applica a una situazione in cui le emissioni globali di gas serra derivanti dall'attività umana sono in equilibrio con la riduzione delle emissioni.
Guardando alle esportazioni, le percentuali diventano ancor più allarmanti, con la fetta di mercato dei Paesi del Golfo e dell'Iran destinata a salire fino al 65% entro la metà del secolo. Secondo l'Agenzia, a pagarne le spese saranno soprattutto i Paesi più vulnerabili e meno preparati per affrontare la transizione energetica. Mentre l'Europa sta procedendo verso un futuro più sostenibile, seppur non abbastanza rapidamente, e gli Stati Uniti hanno riserve interne di petrolio e gas, saranno principalmente i Paesi emergenti dell’Asia orientale a diventare sempre più dipendenti dalle esportazioni del Medio Oriente.

Appare quindi abbastanza evidente che la COP28 a Dubai parte davvero male: a meno che non sia stata provocatoriamente voluta, la scelta della sede somiglia molto ad un convegno di pomposi accademici…nel paese dei Balocchi di Collodi, visto che spesso questa città è stata definita un Luna Park per ricchi. In questo caso però a nessuno spunteranno le orecchie d’asino. L'allungamento del naso stando a quel fanno rispetto a quel che promettono sarà evidente per molti.
La produzione agricola è pressoché inesistente, le oltre
300.000 tonnellate di riso che accompagnano 30 kg di carne bovina, 70 kg di
carne suina e più di 60 kg di pesce che ogni anno in media un abitante consuma,
sono tutte di importazione. E’ uno dei più grandi centri commerciali e
finanziari della Terra e, nonostante la digitalizzazione spinta, vengono
consumate qualcosa come 600.000 tonnellate di carta l’anno.
L’impronta ecologica lasciata da
ogni abitante di Hong Kong è gigantesca: 4 ettari ciascuno. Se tutti i
terrestri avessero un simile impatto occorrerebbero due pianeti e mezzo per
sostenere l’umanità: 4 ettari a fronte di una disponibilità di 0,04 ettari a
testa, il che significa che il 99 percento di quel che occorre per il loro
sostentamento è prodotto consumando risorse altrui, che poi, come abbiamo
visto, è quello che accade normalmente per qualsiasi centro urbano. C’è di
peggio: a Singapore siamo a 5,5 ettari di impronta.
Metà dell’impronta di Hong Kong è dovuta all’emissione di gas serra: il 26 percento di CO2 è prodotto localmente (milioni di condizionatori per consentire di vivere in un clima subtropicale tremendo, milioni di litri di carburante per veicoli e imbarcazioni…), il restante 74 percento viene emessa altrove, da qualche parte del mondo, per produrre quanto si vende o si commercia ad Hong Kong ogni anno. Totale, quasi 100 milioni di tonnellate di gas serra l’anno, un quinto di ciò che produce l’Italia.
Un paradossale ecosistema totalmente costruito dall’uomo,
che ha sostituito foreste e praterie, insenature e rive frequentate fin da
40.000 anni fa.
E questo salto nel passato ci ricorda che ad Hong Kong non hanno inventato nulla: hanno esasperato quanto accadeva già nel Neolitico in una cittadina turca di 8.000 anni fa o nella Roma imperiale, che aveva già una densità di ben 5.000 persone per chilometro quadrato e che, al tempo del suo maggior splendore, importava quasi 4 milioni di tonnellate di frumento l’anno per sfamare i suoi abitanti. E per tornare al nostro tempo e al nostro paese abbiamo Napoli, riferendosi al solo territorio comunale, con ben 8.500 abitanti per chilometro quadro. Candido virtualmente Napoli come sede per la prossima COP29.
Conclusione
Mi ripongo e pongo le domande.
Una conferenza sul clima, una COP, che si tenesse ad Hong Kong, non scatena in voi, come in me, stridore di strumenti non accordati?
E quel che accadrà a Dubai non sarà mica quel che accade
prima di un concerto, tra i suoi 90 elementi d’orchestra sinfonica, senza che
intervenga un direttore a tacitare tutti con i famosi colpi di bacchetta?
Come quando commentai la COP26, assistendo alla realtà delle azioni rispetto ai programmi, attendo la prossima COP con il solito senso, tra seccatura ed amarezza, che si avverte quando si ha la certezza di essere presi in giro.
(*) il 28 novembre scorso è stato annunciato che, per motivi di salute, il Papa non sarà fisicamente presente alla COP28. Ma le vere assenze, ingiustificate e ingiustificabili, sono quelle di Stati Uniti e Cina.
Aggiornamento del 3 dicembre 2023. Le mie erano facili previsioni, realizzate con un'analisi davvero minima di ciò che tiene in piedi l'economia del paese ospitante. Ma oggi l'emiro ha tolto la maschera affermando: "Senza petrolio torniamo alle caverne". Ci sono alternative, costose, ma ci sono. Rileggerei la cosa in questo modo: "Senza vendere petrolio tornano alle caverne. Loro".