E’ dalla storia del nostro
passato che dobbiamo attingere a piene mani, senza emettere inutili giudizi
sulle colpe passate, spesso allora incoscienti, ma è importante conoscerle per
riconoscerle e per comprendere la responsabilità morale che abbiamo oggi sul
futuro. Uno dei fondatori della moderna ecologia, Peter Vitousek, ebbe a
dire «Humanity’s dominance of earth means that we cannot escape
responsability for managing the planet».
Devastazione o disegno?
Un famoso geologo,
Michael Williams,
ha detto una volta: «
La deforestazione è stata l’espressione principale del
processo di trasformazione antropica della Terra». E questa attività parte da lontano, fin dalla
preistoria e forse anche prima. Senza andare troppo in là nel tempo c’è una
mezza dozzina di autori classici come Omero, Teofrasto, Cicerone, Strabone o
Plinio, che citano la deforestazione, con diverse accezioni e scopi altrettanto
variegati. Platone, delle foreste dell’Attica, scrive che «
in confronto a
quello che erano state una volta ciò che ne rimane oggi è come il corpo
scheletrito di un uomo malato» e Lucrezio condanna l’attività degli
agricoltori che «
sospinge giorno dopo giorno i boschi sempre più in alto
lungo i fianchi delle montagne».
«Come cade una quercia o un
pioppo o un pino alto, che i falegnami sui monti troncano con le scuri
affilante per farne chiglia di nave». Omero, Iliade.
Oggi gli scienziati hanno a
disposizione dati paleobotanici, stratigrafici, sedimentari, archeologici, e
altro ancora, conservati in specifici database a disposizione di chiunque
voglia farne uso, che consentono di ricostruire l’andamento dei processi di
scomparsa e/o ritorno delle aree forestali, con o senza cambiamento di specie
arborea per motivi magari climatici, e soprattutto distinguendo tra azioni
naturali o disboscamenti derivanti da precisi piani e scopi antropogenici.

Durante la rigogliosa
Età del Bronzo
come pensate riuscissero ad estrarre il rame dai minerali che lo contengono, a
lavorarlo? Ovviamente fondendo la materia prima in forni alimentati a legname,
dove bruciavano tutto il bruciabile. C’è una famosa area archeologica in
Giordania che è stato un vero e proprio polo metallurgico per quasi 9.000 anni:
dal
Neolitico fino alle
epoche Romana e Bizantina. Sono state ritrovate qualcosa come 250.000
tonnellate di scorie dalla produzione metallurgica, in soli 12 chilometri
quadrati: ci vogliono vari milioni di tonnellate di legname per produrre una
tale quantità di scorie.
E nemmeno occorre andare così lontano. L'antica Populonia era un porto minerario sul promontorio di Piombino (LI), e fu il più celebre centro siderurgico dell'antichità destinato alla fusione della maggior parte del ferro estratto sull'Isola d'Elba. Furono prodotte, in tempi relativamente brevi, qualcosa come due milioni di tonnellate di scorie, alterando la composizione del suolo e producendo colline artificiali che sepolsero intere necropoli. Le fornaci erano alimentate a carbone: si è calcolato che per produrre circa 100 kg di carbone occorrevano circa 15 alberi del diametro di circa 15 cm!

Nuovo Mondo. Da Panama al
Brasile, con la foresta amazzonica simbolo mondiale dei danni da
deforestazione, ci sono le prove scientifiche che l’attività dei
cacciatori-raccoglitori, sovrapponendosi agli effetti delle variazioni
climatiche, ha avuto effetti profondi sulla struttura delle foreste tropicali
di bassa altitudine, molto prima dell’invasione europea. Le tracce nei
sedimenti, essenzialmente pollini arborei, aumento del carbone d’origine
vegetale, grani di amido e
fitoliti
del mais, indicano chiaramente la maturazione di un’economia agricola basata
sulla tecnica del “
taglia-e-brucia”.
7.000 anni fa. E quando arrivarono i
conquistadores, gli stessi
indicatori mostrano un’inversione di tendenza, tornarono gli alberi. In queste
aree le popolazioni native subirono una terribile decimazione a causa dei
massacri, delle malattie e delle deportazioni. E le foreste in molti casi si
infittirono. Insomma, la foresta,
vergine, non lo era affatto. Così
come, dall’altra parte del mondo, non erano affatto vergini i territori
scoperti
dagli europei, l’Australia, la Nuova Guinea, la Tasmania, la Nuova Zelanda, già
abbondantemente rimodellate a tratti, dalle popolazioni aborigene anche loro
dedite al controllo del fuoco ed al suo impiego per modificare a loro vantaggio
il territorio.
Certo l’uomo, lì come altrove,
non ha fatto tutto da solo: c’è sempre un elemento «naturale»
oltre che «culturale», soprattutto climatico,
che consente di riconoscere una sostanziale azione congiunta tra quest’ultimo e
gli esseri umani.

La polemica tra i sostenitori
della «devastazione» contrapposti a quelli che
parlano di «disegno» non si esaurirà mai, è
antica, così come antica è l’azione che l’umanità esercita nei confronti
dell’ambiente. Ma c’è qualcuno che rifiuta l’assunto tradizionale «trasformazione=degradazione» interrogandosi, ad
esempio, sul reale funzionamento degli ecosistemi del bacino del Mediterraneo,
a cui tanto deve la storia dell’umanità, «disegnati»
dall’uomo nel Neolitico e costruiti nei secoli e nei millenni di perfezionamento
dell’agricoltura e delle sue tecniche. Oggi che va così di moda il termine sostenibilità ci si
dovrebbe chiedere se quanto realizzato finora non lo sia davvero, sostenibile,
visto che per secoli ha egregiamente funzionato. E addirittura, anche se il
verdetto per la gestione della cosiddetta biodiversità è decisamente negativo, con la distruzione
sistematica e un’ecatombe floro-faunistica, i sostenitori del «paesaggio disegnato» non negano la scomparsa di tutte
o quasi tutte le specie originarie ma affermano che ciò che ne seguì non fu il
vuoto, ma l’introduzione di una comunità di altre specie, domestiche o
selvagge, importate o trasportate involontariamente.

E, sembra un paradosso, ma non lo
è, l'ecologia delle comunità riconosce che il «disturbo»,
sia esso antropico meno, non è necessariamente un fattore negativo per la
biodiversità. Numerosi studi in proposito dimostrano che il massimo livello di
biodiversità non si registra generalmente in assenza di perturbazioni bensì in
corrispondenza di valori intermedi di disturbo. L’estrema variabilità della
strategia produttiva agro-silvo-pastorale, che nel Mediterraneo ha la sua
massima espressione, sostanzialmente ottenuta con pratiche di moderato disturbo
ambientale, hanno consentito di mantenere elevati valori di biodiversità.
Sembra incredibile.
A questo punto chiedersi in
quanto tempo è avvenuto tutto ciò è obbligatorio: in un tempo sufficientemente
lungo da permettere ai filosofi e ai poeti di raccontarci di qualcosa di così
lontano nel tempo da renderlo irreale. Non così velocemente da non consentirci
di adattarci o, meglio ancora, dar tempo alla componente biologica di
adattarsi.
Tutta questa lunga e, solo in
apparenza fuori tema, premessa, per arrivare al punto: abbiamo memoria di tutto
ciò? Sappiamo o sapremo farne buon uso? E se ne abbiamo memoria, di che tipo è?
Recentemente scrivevo:
«è il sapere come sono andate le cose in passato che rende evidente che la
nuova normalità climatica è conseguenza diretta delle nostre attività». Per
estensione, la nuova visione ecologica.
La memoria corta dell’uomo
moderno
Nel 2013, in un autorevole testo
di divulgazione scientifica, si scriveva: «La temperatura media globale è
aumentata di 0,6 °C nel corso del XX secolo. I dieci anni più caldi del secolo
che ci siamo lasciati appena alle spalle sono tutti nella sua parte finale e le
loro temperature sono state le più elevate dell’ultimo millennio».
A distanza di un altro decennio
anche questi ulteriori dieci anni appena trascorsi sono stati segnati da record
di temperature medie via via crescenti e, per ora, il vincitore è questo 2023.
E i prossimi dieci anni faranno di tutto per battere
quest’ultimo.

La globalizzazione e l’iper-connessione,
pressoché impossibili da evitare, stanno portando l’umanità a perdere memoria:
l’orizzonte temporale dell’uomo contemporaneo diventa sempre più piccolo, uno
spazio emotivo che si fa sempre più contingente, valido ora e qui e basta.
Sempre nuove emozioni regolate dai media nascono nel giro di pochi giorni, ore
e minuti, per poi lasciare spazio all’oblio rispetto a ciò che fino a un
istante fa sembrava tanto preoccuparci. Le informazioni si affollano e si
ingorgano, costringendoci a sviluppare una notevole capacità di dimenticare per
poterne gestire, divorandole, continuamente di nuove. E per ogni quantitativo
di informazioni c’è
una parte, coscientemente gestita da chi ne ha interesse, opportunamente
mescolata, che consiste di disinformazioni.
Dimenticare è più necessario che ricordare, per far posto a continue nuove
immaginazioni di massa che consentano a miliardi di individui di vivere
consumando dentro ecosistemi artificiali, senza pensare al proprio destino. Le
dimensioni economico finanziarie della nicchia auto costruita dall’uomo sono
forse irrinunciabili, ma avvolgenti e soffocanti.

I demografi ormai non parlano più
di
popolazioni ma di «
metapopolazione»,
per descrivere questo insieme di popolazioni locali riunite in una generica
rete genetico-demografica. E per quanto assurdo possa sembrare eravamo una
metapopolazione persino quando, alla fine del
Paleolitico, una decina di
millenni fa, sulla Terra c’erano più o meno 5 milioni di individui!
Sì, perché
è stato grazie alle migrazioni, allo scambio, all’apporto genetico e culturale,
che i piccoli, piccolissimi gruppi di esploratori, a volte meno di 100
persone, hanno evitato l’estinzione.
Questa perdita della memoria è
paradossalmente antitetica rispetto alla profondità della storia umana e alle
sue complesse traiettorie. L’oblio che governa la maggior parte della vita
delle società attuali appare tragicomico rispetto alla grandiosa capacità che
l’uomo contemporaneo ha sviluppato di leggere e interpretare gli archivi
storici costruiti negli ultimi 5.000 anni, e quelli ben più profondi costituiti
nel tempo dall'uomo preistorico, dalle flore e dalle faune, dai vulcani e dal
clima, e ora depositati negli strati geologici ed archeologici e nei sedimenti
dei laghi e degli oceani.
A cosa dovrebbe servire
ricostruire il passato remoto dell’umanità e dei suoi innumerevoli modi di
stare e agire negli ecosistemi della terra? Sarebbe tragico
se tutto ciò venisse letto con pregiudizio, per sostenere falsi miti
ambientalisti dell’Eden perduto o del valore intrinseco dell’immutabilità
ecologica costruiti a priori. Sarebbe criminale se
venisse utilizzato per creare giustificazioni e fatalismi, strumentali a gruppi
interessati solo alla produzione ed al profitto senza scrupoli.

Ma non
facciamoci troppe illusioni: non può servirci neppure a predire con
esattezza deterministica cosa ne sarà di noi e degli ecosistemi del pianeta.
Dispiace doverlo dire così brutalmente ma, contrariamente al ritornello di
molte introduzioni all’analisi eco-antropologica, il fatto che ci troviamo, fin
dalla nostra origine, immersi in un cantiere bio-culturale continuamente aperto,
e saltiamo da una transizione all’altra limita molto la possibilità di farci
un’idea precisa nel nostro futuro studiando il nostro passato. Possiamo
amplificare il dettaglio conoscitivo di formazioni geologiche, strati sedimentari,
orizzonti archeologici, ma non avremo mai la possibilità di immettere tutto ciò
in un algoritmo che automaticamente sia in grado di estrapolare il nostro
futuro. E il perché sta tutto in questa considerazione:
«Tutti i sistemi semplici sono
semplici allo stesso modo; ogni sistema complesso è complesso a modo suo».
E se la sola atmosfera è un sistema complesso al limite dell’indecifrabilità
immaginate quanto possa esserlo l’insieme di atmosfera, idrosfera, litosfera,
idrosfera, biosfera…e antroposfera!
Non esiste un’antitesi
uomo-natura
Pur essendo a conoscenza dei
fatti che ci riguardano non dovremo perdere di vista che stiamo eseguendo un
esperimento planetario, e ne siamo al tempo stesso le cavie. Conoscere, anche
con precisione, come sono cambiati i numeri della popolazione globale negli
ultimi 10.000 o 100.000 anni, non ci serve a capire automaticamente quanti
saremo tra 100 anni. Per quanto ne possiamo sapere su antiche popolazioni e sul
loro stile di vita ciò non ci darà automaticamente la ricetta della
sostenibilità.
Allora
perché ricordare? Ragionare sul passato della Terra e sul nostro può
servire soprattutto a prendere coscienza della storia naturale delle nostre
dimensioni ecologiche, a comprendere senza pregiudizi che siamo sempre stati
parte della Natura, e al tempo stesso a capire che la manipolazione degli
ecosistemi è una caratteristica antropologica profonda, che ci accompagna dalle
origini. Che sia devastato o disegnato questo nostro ambiente, non possiamo
dubitare che il ruolo ecologico che l’uomo ha assunto nell’Olocene, con il Neolitico
l’Età del Bronzo, è assolutamente conseguente alla storia remota della nostra
specie e che l’impronta ecologica ha cessato di essere marginale o meramente
locale ben prima della rivoluzione industriale. Riconoscere questo ha una
straordinaria importanza per orientare in modo corretto la ricerca delle
soluzioni possibili al problema della sostenibilità, perché possibile vuol dire
innanzitutto coerente con la nostra storia naturale di costruttori di nicchia.
Da questo
processo preistorico abbiamo imparato che contrapporre l’azione dell’uomo
rispetto ai processi naturali non è giustificato dalla lettura del passato.
Oggi che abbiamo davanti agli occhi un’impronta ecologica che non sembra più
avere limiti l’idea che l’azione dell’uomo sia sempre integrata con quella
degli altri componenti naturali, e che addirittura non sia necessariamente
negativa, può sembrare assurda, visto che da sempre lo si è collocato a priori
fuori e in antitesi rispetto alle dinamiche naturali.

Questa antitesi natura-uomo domina
la letteratura di divulgazione sulle tematiche ambientali e i libri di testo di
ecologia. La definizione di impatto antropico sugli ecosistemi è una metafora
potente e abusata di questa idea che pervade anche molta letteratura
scientifica specialistica. Ma considerarci fuori dalla
natura è sbagliato e pericoloso. Sbagliato perché la nostra, anche nell’Olocene,
è storia naturale di una specie culturale. L’ostinazione
a leggere le trasformazioni ambientali sempre in modo antitetico, l’uomo o i processi naturali, ha generato confusione e prodotto
errori.

In un recente
post,
abbiamo visto come gli incendi, che rappresentano uno dei più importanti
fattori ecologici che controllano la struttura e il funzionamento degli
ecosistemi terrestri, sono da almeno 50.000 anni sotto il controllo
strettamente integrato del clima e dell’uomo. Ancora, la scomparsa delle grandi
faune del
Pleistocene è
dovuta a una stretta complicità tra uomo e clima. Non è possibile leggere la
storia delle modificazioni dei paesaggi degli ultimi 10.000 anni se non in
termini di stretta integrazione e di continue retroazioni tra «
cultura» e «
natura».
L’aumento della capacità di controllo sugli ecosistemi che l’uomo ha sviluppato
nel corso del Pleistocene e dell’Olocene ha determinato, secondo la visione
dualistica, il passaggio da una fase
nature
controlled a una
human dominated. Ma questo dominio non solo non ha
mai messo al riparo la cultura dalla natura, ma siamo già dentro un’epoca in
cui paradossalmente il dominio umano sugli ecosistemi della Terra sta
determinando nuovi e più elevati livelli di vulnerabilità dei sistemi socioeconomici rispetto alla variazione dei fattori naturali, come il clima. La
velocità del cambiamento che abbiamo innescato è tale da farcene perdere il
controllo che credevamo di aver raggiunto.
L’antitesi è anche pericolosa
perché la sensazione o la pretesa di essere altro e fuori dalla natura è sempre
stato l’alibi per sentirsi privilegiati ed esercitare il dominio ecologico
autorizzato o, di contro, la premessa per la nascita di utopie e ambientalismi
assolutamente improduttivi. Quello che serve ora non è
sentirsi colpevoli ma responsabili, e la consapevolezza
di starci dentro è esattamente ciò che serve a sviluppare una maggiore
responsabilità ambientale. La colpa ecologica è molto antica ma sarebbe
ridicolo esprimere una condanna sul passato. Quanto potevano i cacciatori-raccoglitori
che annientarono le macrofaune in America, o i proto-agricoltori che già
praticavano il taglia-e-brucia in Eurasia 11 millenni fa, essere
consapevoli delle conseguenze ecologiche a lungo termine delle proprie azioni?

Oggi però
non abbiamo attenuanti: la consapevolezza è piena. Migliaia di sensori
installati e volutamente messi in orbita nello spazio extraterrestre ci
informano in diretta sulle trasformazioni che la nostra azione produce. I
modelli matematici dei climatologi non lasciano adito a dubbi sulle conseguenze
della deforestazione delle emissioni dei gas serra. Le tecniche dei demo-ecologi
ci permettono di valutare le probabilità di estinzione delle popolazioni
naturali.
Ricordiamo ancora le parole di Vitousek, citate
all’inizio: «Humanity’s dominance of earth means that we cannot escape
responsability for managing the planet».
Capire che le colpe dell’uomo
sono sempre state legate a doppio filo alle cause naturali serve anche a
comprendere che il nostro destino, così come la nostra storia, non sono indipendenti da
quello del resto del pianeta, e a toglierci ogni
illusione sulla possibilità, o presunta capacità, di tirarci fuori all’ultimo momento da
questa storia se le cose dovessero mettersi veramente male.
Se dovessimo fare un processo al comportamento dell'umanità imputato e
giudice sarebbero la stessa persona, ma colpevole e vittima non si possono
separare, se non, per paradosso, nei casi di suicidio.
Nota bibliografica: liberamente ispirato al Cap. VII de “L’impronta originale” di Guido Chelazzi. Einaudi, 2013
Il
dominio dell’umanità sulla terra significa che non possiamo sottrarci alla
responsabilità di gestire il pianeta.
Mi si perdoni l’aver inserito l’antroposfera come un altro da sé della biosfera.


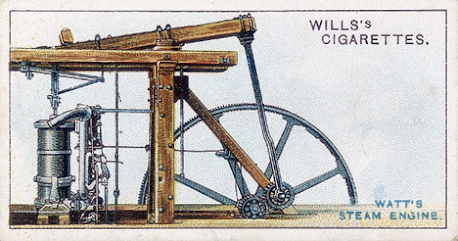












Nessun commento:
Posta un commento
L'Amministratore del blog rimuoverà a suo insindacabile giudizio ogni commento ritenuto inadeguato od inappropriato.
Per motivi tuttora ignoti anziché un account Google come da impostazione, ne viene richiesto uno Blogger. In altre parole, per ora non potete sottoporre commenti, a meno che non abbiate, appunto, un account Blogger. Spiacente.